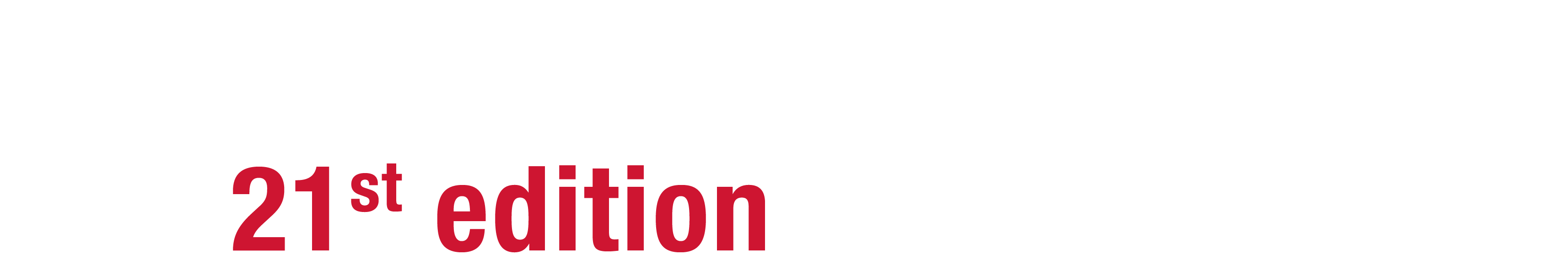A cura di Federica Fabbiani e Chiara Zanini, con l’aiuto di Emmanuelle Bouhours. Traduzione di Federica Fabbiani. Tratta da Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma, Asterisco, Milano, 2021
Questa intervista è tratta da Architetture del desiderio. Il cinema di Céline Sciamma. Il volume, primo in assoluto dedicato alla regista francese, vede come autrici Federica Fabbiani, Chiara Zanini (anche curatrici), Daniela Brogi, Elisa Cuter, Ilaria Feole e Silvia Nugara. La postfazione è affidata a Ilaria A. De Pascalis. Pubblicato nel 2021, è stato presentato nel corso della 78a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica a Isola Edipo e si può acquistare presso i bookshop Electa al Lido oppure on line dal sito della casa editrice Asterisco e in molti punti vendita anche on line.
Buongiorno Céline, grazie per la disponibilità. Lei ha scritto la sua opera prima, Naissance des pieuvres, quando ancora frequentava La Fémis, dove si è diplomata in sceneggiatura. Aveva già ottenuto una laurea in Letteratura francese. Ha sempre confermato di non aver pensato subito di fare la regista e che è stato il cineasta Xavier Beauvois, membro della commissione di fine corso, a suggerirle di dirigere il film. È assai inusuale debuttare alla regia con un lungometraggio, eppure, successivamente al diploma e dopo qualche incontro con dei produttori ha incrociato sulla sua strada Les Productions Balthazar, con cui ha appunto realizzato Naissance des pieuvres. Com’è stato questo passaggio dalla scrittura alla regia?
In realtà non saprei dire se non mi riconoscevo nel ruolo di regista o se non avessi ancora completamente compreso come collegare regia e scrittura. Perché non provavo il piacere letterario della scrittura e non avrei voluto scrivere dei romanzi, ad esempio. Scrivere un soggetto cinematografico è pensarne la regia. Il collegamento è diretto, ma io allora non avevo ancora chiaro come inserirmi all’interno di quel processo. Sono stati gli altri a dirmi che la mia scrittura possedeva già gli elementi registici, di forma e di struttura, per procedere da sola. Quando l’ho visto anch’io, è diventata la cosa più evidente della mia vita.
Lei ha dichiarato: «Ho passato la vita ad amare film che a volte mi odiavano, identificandomi con Superman, ad esempio». Quali sono le autrici o gli autori che hanno contribuito alla sua crescita e che oggi considera affini al suo percorso, alla donna che è oggi?
Ci sono due modi per rispondere a questa domanda. C’è la verità della cronologia con i registi che incontriamo durante gli anni della nostra formazione di cinefile e che ci cambiano. E qui c’è Noémie Lvovlsky, la prima che ho identificato come regista donna. C’è David Lynch, che mi sembrava sperimentare tanto sul tema del femminile, qualcosa che sentivo molto; e anche la francese Patricia Mazuy. Tuttavia per me è forse più interessante rispondere al presente, ossia con tutto quello che ho scoperto in termini di storia e cultura della regia delle donne che all’epoca neppure conoscevo, e che mi permette di fare dei collegamenti con delle opere che scopro oggi. Questa è la ragione per la quale voglio citare il lavoro di registe di cui non avevo visto i film, come Alice Guy, Mabel Normand, Chantal Akerman, Yannick Bellon, Germaine Dulac, Marie Epstein. Questo per me è più interessante che dire se e quanto Steven Spielberg sia stato importante per me. Ci sono cose che non sono state trasmesse ma che sono state recepite, in un modo o nell’altro.
Allora si può quasi parlare di influenze retroattive da parte delle registe che ha citato?
In realtà non amo parlare di influenza, preferisco pensare a dei punti in comune. Mi piace fare la lista delle cose che non conoscevo ma che avevano già dei punti in comune con me. Sono stata influenzata dal cinema, da quel tipo di linguaggio. Dal cinema come vita. E avevo voglia di viverlo. Mi colloco diversamente rispetto a questa idea delle influenze, forse perché sono una donna.
La sua trilogia si concentra sull’adolescenza femminile, il che è abbastanza inusuale dal momento che i film di formazione si concentrano in genere sui ragazzi, sulla loro attitudine all’esplorazione, al cameratismo, alla lotta per affermarsi nel mondo. Come cambia la narrazione quando le protagoniste sono ragazze?
Non credo affatto alla possibilità che avvengano dei cambiamenti solo perché ci sono dei personaggi femminili. Non credo neanche che la questione debba essere posta in questi termini, se si ambisce a una rappresentazione davvero nuova. Generalmente se scrivendo una sceneggiatura ci si chiede «E se fosse una donna?» non ci si sta spostando per niente. Rimane una questione puramente accessoria. Mettere in scena una poliziotta violenta o una presidente della repubblica guerrafondaia o pacifista non produce alcun cambiamento reale secondo me. Nessuna vera differenza, e questo perché sono all’opera sempre le stesse strutture. La questione non è il genere dei personaggi, ma la volontà di manomettere le strutture. Qualunque tipo di struttura: le convenzioni del cinema come si esprimono nelle forme del racconto, il patriarcato tutto. Se non c’è un personaggio femminile che mette in crisi la struttura patriarcale, non è stata apportata alcuna differenza e niente cambierà. Quando c’è un personaggio femminile cambia qualcosa solo se c’è una diversa attitudine nei suoi confronti, se condividiamo la sua soggettività e se comprendiamo le situazioni che si trova ad affrontare. Non è inserendo un solo personaggio femminile che si può sperare di fare una rivoluzione, perché lo spazio della cultura e lo spazio della finzione non sono un posto sicuro per le donne. Siamo ancora in quella stessa struttura patriarcale che dobbiamo manomettere e nel quale le donne non si sono mai salvate. È per questo che ho dichiarato che ho passato la mia vita ad amare dei film che mi detestavano. Quei film erano pieni di aggressioni verso le donne e soprattutto non mi mettevano mai in connessione con la soggettività e l’esperienza dei personaggi. E questa è davvero una forma di violenza.
E come si può realizzare questa manomissione della struttura?
Il capovolgimento della struttura patriarcale si può ottenere anche mettendo il personaggio femminile in una situazione di oppressione, ma questa situazione deve essere condivisa. Non si tratta di costruire delle utopie, ma di condividere il punto di vista. Se si pone il personaggio femminile nella condizione della vittima, di chi è abusata o aggredita, bisogna essere dalla sua parte. E questa è la direzione che sta prendendo la fiction, il che la porta in molti casi su un piano che è anche politico e che, come tale, può avere una ricaduta sociale. Basti pensare ai cataloghi delle piattaforme di streaming, ad esempio: è chiaro che è un modo per sedurre certe nicchie di pubblico e che quindi ha anche ragioni economiche. Ma questa è la fabbrica dell’immagine che cerca, nei suoi momenti migliori, di coniugare arte e profitto. Per me è un bene che questa, che, non dimentichiamolo, è e rimane un’industria, porti gli artisti a impegnarsi anche politicamente per essere all’altezza di un pubblico che spesso è molto preparato, molto più preparato degli artisti medesimi.
Lei ha raccontato infanzia e adolescenza senza essere presente sui social network. Oppure lo è? Qual è il suo punto di osservazione per un’età che nessuna capisce mai?
Uso molto Twitter e Instagram e faccio “turismo” su Tik Tok. Considero i social una possibilità in più per informarmi, ridere, imparare e soprattutto capire gli altri. Ma non li uso per documentarmi sulla giovinezza come se si trattasse di un’età da capire. Non lo è. È un’età che tutte abbiamo attraversato e che capiamo benissimo. Si può solo scegliere se disprezzarla oppure rispettarla. Sono circa trent’anni che la gioventù è disprezzata, almeno in Francia: è disprezzata dai genitori, dalla sinistra, perché la mia generazione è cresciuta in una Francia di sinistra, o almeno che si dichiara di sinistra. Io frequento i social perché sono un’entusiasta.
Pensa che un’adolescente che guarda i suoi film possa capirsi meglio? Era questa una delle sue intenzioni nel proporre la varietà di temi che la trilogia presenta, come ad esempio la scoperta del desiderio, l’inquietudine sull’identità di genere, la non sempre semplice appartenenza a una comunità?
Certo. C’è sempre un progetto in tutti i miei film, e io mi rivolgo direttamente alla spettatrice e allo spettatore. Ho sempre in mente la persona cui voglio rivolgermi e ogni film ha un suo progetto specifico. Naissance des pieuvres si rivolge alla ragazza che è sola. Tomboy parla sia agli adulti che si portano dentro il bambino che sono stati, sia ai bambini, e da questo punto di vista lo considero un film riuscito, perché è esattamente quello che è accaduto. La mia idea è sempre cercare di capire a chi voglio parlare quando il pubblico si siede nel buio della sala cinematografica. E questa sala non doveva avere solo persone bianche tra il pubblico di Bande de filles, doveva avere varie generazioni di donne per Ritratto della giovane in fiamme, e spero avrà adulti e bambini in egual numero nel prossimo film [Petite maman, N.d.T].
Lei ha dichiarato che il cinema è l’unica arte che permette di mostrare la solitudine dei personaggi, delle personagge nel suo caso. Il che spesso mette a nudo la loro vulnerabilità. E lo fa non tanto attraverso l’analisi psicologica, ma attraverso l’esposizione dei corpi, al modo in cui si conformano o ribellano al disciplinamento imposto dalla società patriarcale e dallo sguardo maschile. C’è in tutti i suoi film uno stato di quasi raggiungimento dell’unione con l’altro da sé, sia nella forma singolare sia collettiva, ma non dura mai. L’unico modo per sopravvivere è farcela da sole?
Sì, è quello che penso. Non l’avrei mai detto agli esordi, ma penso che riguardi più le esperienze che si fanno nella vita che non il cinema. Credo che si sia sempre responsabili della propria vita e questo è inevitabilmente in relazione con la solitudine. Essere responsabili significa guardarsi, mettersi in discussione, avere un dialogo continuo con sé stesse e, partendo da quella solitudine, darsi un obiettivo con e per gli altri. Penso poi che quello che ci raccontano che è meglio vivere in due, formando delle piccole unità chiuse, sia certo rassicurante, ma anche fondamentalmente contrario all’idea di comunità. Per me è nei collettivi che si possono trovare i legami più autentici, più utili, profondi e anche più onesti rispetto a quelli che si creano in una storia d’amore o nelle famiglie. È questa la ragione per la quale nei miei film si finisce da sole. Non è una questione di solitudine o abbandono. Mi chiedo sempre cosa sia questa unione che ci vendono sempre come unica e vera prospettiva di sviluppo e felicità. Nei miei film la fine non ha niente a che vedere con la felicità o l’infelicità, perché quello che mi interessa davvero è individuare un processo di sviluppo che porti a una trasformazione. E qui si ritorna quindi all’idea necessaria della responsabilità individuale che tanto peso ha nelle trasformazioni personali. Se ci si guarda intorno, non si fa fatica a vedere come il blocco sia spesso dato da chi si rifiuta di trasformarsi, da chi non riconosce i propri errori, da chi teme di aver anche solo voglia di cambiare.
La colonna sonora, anche nella forma dei suoni dei corpi o degli oggetti, è una parte che lei cura molto. Come è pensata e come si inserisce nelle varie fasi – ideazione, riprese, montaggio – del film?
La musica è qualcosa cui penso già durante il processo di scrittura, indipendentemente dal fatto che decida di inserirla oppure no. In Naissance des pieuvres, per quanto fosse la mia prima volta, sapevo che avevo bisogno di una vera e propria colonna sonora. Un pezzo epico finale e una musica originale, il che ha portato ad avere brani anche molto diversi, senza un vero legame tra loro. In Tomboy, invece, ho voluto solo una canzone, anche in questo caso originale, composta appositamente per il film. Per Bande de filles ho scelto la musica di Rihanna, una cantante famosa e di successo, che trasmettesse esattamente l’idea di qualcosa che cresce. E nessuna colonna sonora nel Ritratto della giovane in fiamme, di nuovo solo un brano originale, composto per il film e che ho avuto a disposizione anche prima di girare. Non ho mai acquistato i diritti per la musica dei miei film, fatta eccezione per Rihanna e i pezzi di musica classica. Comunque ogni volta è una storia diversa: per il prossimo film ad esempio ho già parlato con il compositore indicando quello di cui ho bisogno, ma poi avrà piena libertà di azione. Dopo aver letto la sceneggiatura, ha due o tre mesi per comporre la musica. Quindi se poi ho i pezzi musicali prima di girare va bene, altrimenti ne faccio a meno, non è affatto grave.
La scena dell’aborto nel Ritratto della giovane in fiamme ha fatto molto parlare perché è forse quella che più ci invita a riflettere sull’autodeterminazione della donna piuttosto che su altri aspetti. Ed è inserita in una storia destinata a diventare un classico del femminismo. Le donne protagoniste formano un microcosmo autosufficiente, realizzando una sorta di utopia. Era questa la sua intenzione fin dalla prima stesura? È nata perché anche lei avvertiva l’assenza di una trattazione senza giudizio del tema dell’aborto?
Sì, volevo una scena con un aborto nel film e mi serviva sostanzialmente per mostrare due cose: che si può rappresentare un aborto, che è qualcosa di estremamente raro al cinema, e che può anche non essere un episodio isolato dal contesto, ma integrato totalmente nella dinamica narrativa del film. Era per me un passaggio necessario.
La sua straordinaria riflessione sullo sguardo e sul “female gaze” nel Ritratto della giovane in fiamme pone il film in dialogo con le arti visive in generale. Per esempio, secondo noi, con il lavoro delle artiste femministe degli anni Settanta. È d’accordo? E eventualmente può dirci alcuni dei riferimenti di quella stagione che più l’hanno interessata?
Sì, sono d’accordo. E anche in questo caso i riferimenti delle donne artiste sono validi per me oggi, nel presente. Non mi piace raccontare la vita come una serie di shock estetici che ti fanno diventare quello che sei. Sono sensazioni e come tali vanno accolte. Per farla breve, mi viene da citarle tutte. Louise Bourgeois, tutte le artiste di questo periodo e successivi, le impressioniste, Mary Cassatt, Berthe Morisot. Penso a tutte le epoche. Judith Leister. Francesca Goodman per la fotografia. Ma in effetti io passo dal lavoro di una donna all’altra, cercando di imparare da tutte. Nel Ritratto c’era proprio quest’idea di rappresentare tutte le arti, quindi pittura, disegno, ricamo, musica, canto. Manca solo la danza. E vediamo queste donne praticare tutte queste arti, la letteratura, la poesia, la filosofia.
Come lavora alla fotografia con la d.o.p. Claire Mathon? Quanto condivide con collaboratori e collaboratrici dei suoi film?
Ho un metodo di lavoro molto partecipativo con tutti i miei collaboratori e nei confronti di ognuno c’è totale rispetto delle competenze personali. Non penso che sia un lavoro solitario in cui mi devono portare qualcosa che ho chiesto. È un processo fortemente collaborativo, cui tutti contribuiamo in modo corale. Anche con Claire Mathon si parte dall’idea e iniziamo a parlare molto presto del desiderio per il progetto, creando e alimentando il desiderio attorno al progetto stesso in modo che si attivi qualcosa in lei ancora prima di aver letto la sceneggiatura. Poi si legge, si discute, si fanno delle prove, si ritaglia in piani e in sequenze il film. Alla fine è più un dialogo filosofico che tecnico. Per il Ritratto abbiamo riflettuto molto su cosa sia un film storico. Oggi stiamo lavorando diversamente, ad esempio, e per il nuovo film ci stiamo concentrando sulla luce. La lavorazione cambia a seconda di quello che più si vuole approfondire attraverso il film, ma molto dipende dal dialogo che riusciamo a creare insieme. Ho davvero una fiducia totale in lei e in realtà penso che, anche senza parlare, lei capirebbe comunque. Rimane che è davvero bello avere questo scambio e “nutrirci” a vicenda con questo tipo di dialogo.
Il suo cinema dialoga continuamente e creativamente con l’opera di Agnès Varda. Qual è, a suo parere, la sua eredità?
Prima di tutto, la sua vita. Per me la sua eredità risiede tutta nella sua contemporaneità. Ha sempre guardato davanti a sé, è stata lei a filmare le Pantere Nere, lei a parlare di aborto. È sempre stata all’avanguardia ed è davvero stata una grande contemporanea. Per me, è questa la sua eredità. Sapere dove guardare. Come ha politicizzato il suo sguardo e come ha reso la sua vita così grande, così bella. Questo è il suo esempio per me. La gioia di essere contemporanee. Cerco di vivere così tutto il tempo.
In quale contesto si inserisce la sua produzione all’interno della cinematografia francese? Abbiamo saputo della contestazione della gerarchia dell’Accademia dei César [nel febbraio 2020 i vertici si sono dimessi], della creazione del Collectif 50/50 di cui lei è co-fondatrice e della critica che le ha rivolto Michel Ciment. Ci può dire di più al riguardo, in modo che il pubblico italiano possa comprendere meglio in quale clima nascono i suoi film?
Credo che il clima non sia molto diverso da quello italiano, ma certamente l’industria cinematografica francese è diversa rispetto a quella italiana. Tuttavia non siamo due paesi così lontani, anzi in realtà Francia e Italia sono paesi che tendo a accomunare, almeno per quel che riguarda la ricezione dei film, ad esempio. Me ne accorgo anche solo dalle domande dei giornalisti, tendenzialmente è subito chiaro quali sono le priorità di un paese in base alle domande che vengono poste. Il vantaggio di aver fatto dei tour in giro per il mondo è riuscire in breve tempo a percepire le diverse culture politiche della critica, e Francia e Italia sono abbastanza simili in questo. Penso che le registe italiane affrontino temi e problemi in modo simile a me. Il Ritratto ha permesso di capire molto in questo senso, e non solo da un punto di vista cinematografico e filmico.
A che punto è il lavoro del Collectif?
Entriamo nel terzo anno con un consiglio di amministrazione completamente rinnovato. Né io, né le altre co-fondatrici ne facciamo parte, quindi ci sono nuove dinamiche e nuove persone che lo gestiscono e di questo sono molto felice. Oltre alle tante cose di cui abbiamo bisogno e per le quali c’è ancora molto da fare, è stato chiaro proprio durante quest’anno che serve un organo che abbia un peso nelle trattative politiche per ottenere dei cambiamenti e raggiungere gli obiettivi prefissati. È uno strumento molto utile e credo ancora necessario.
Qual è il suo giudizio rispetto al Fonds images de la diversité del Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)? In Italia non abbiamo un organismo che sostenga gli autori stranieri o di seconda generazione, mentre in Francia ci risulta si lavori molto a riguardo.
La Francia ci lavora molto perché il cinema è importante e perché produce un numero enorme di film. Ed è fantastico lavorare affinché una parte di questi film possano sperimentare, proporre nuove idee e lanciare nuovi autori e autrici. Dopodiché ci si può chiedere se questo sia sufficiente. Ormai questi fondi esistono da molto tempo e non è che ci siano state tutte queste novità su chi riesce a prendere parola in Francia. Anche se rimane vero che almeno esiste una politica dedicata a questo problema e che c’è una volontà da parte dei politici di cercare di cambiare le cose. Bisognerebbe riuscire a chiedere dei cambiamenti ancora più grandi. Tuttavia il sistema francese in questo è unico al mondo e io lo difendo e lo apprezzo molto. È qualcosa che bisogna incrementare, sostenere e promuovere anche a livello europeo.
Cosa pensa della maggiore attenzione che stanno ricevendo i film diretti da donne dopo la marcia cui ha partecipato con Agnès Varda, Cate Blanchett e moltissime altre cineaste a Cannes? L’impegno del direttore generale del festival è stato preso ad esempio e il Festival di Torino, per citare il caso più recente, ha scelto di darsi una giuria di sole donne. Sono solo strategie di marketing oppure c’è una reale esigenza di cambiamento?
Certamente crea nuove opportunità. E non la si può considerare solo un’operazione di marketing, perché una giuria decide davvero un premio e la composizione di questa giuria può consentire di valorizzare opere diverse. Questa è una cosa assolutamente necessaria, ma anche in questo caso non può essere sufficiente. E mostra il punto in cui siamo. Si ottiene la parità perché facciamo firmare dei documenti a delle persone, che così si impegnano per mantenere tale obiettivo. Quindi sì, è fantastico, ma è solo l’inizio. Un punto di partenza. Sono comunque ottimista, perché le donne hanno talento.
Può parlarci dei film di cui è stata sceneggiatrice con la regia di altri?
Ci sono film che sono stati fatti e altri che invece non sono stati realizzati. Di quelli che sono arrivati in sala, c’è La mia vita da Zucchina, che è stata una bella opportunità per me anche e soprattutto per la possibilità di rivolgermi ai bambini. Ho una passione per i film di animazione che ho iniziato a coltivare da adulta ed è stata una bella esperienza. E anche un grande successo. Poi c’è stata la collaborazione con André Techiné per Quando hai 17 anni e in quel caso si è trattato di coronare il sogno della mia adolescenza. Techiné è un regista che ho guardato, amato, studiato quando ero più giovane, e trovarmi seduta a una scrivania a lavorare con lui è stato come affrontare un rito di passaggio.
Cosa pensa del dibattito sulle cosiddette “terf” (Trans-Exclusionary Radical Feminists) e su artiste come la scrittrice JK Rowling che utilizzano ampiamente la propria fama e la propria arte per diffondere un discorso d’odio? Sul termine “terf” è intervenuta nei giorni scorsi anche Judith Butler, ha sentito?
Impossibile parlare dopo Judith Butler. Posso solo ringraziarla per aver preso parola, in realtà. C’è un eccesso di attenzione su quello che dice e fa JK Rowling che trovo davvero sproporzionato. Dà peso e valore a un’idea che non è realmente condivisa. Non è un’idea così diffusa, credo. È agghiacciante.